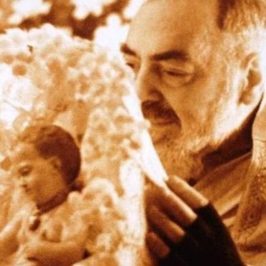Non è semplice ritrovare reperti e residui di cibo, eppure spesso gli studi archeologici ci hanno fatto questo prezioso dono. In Molise, ad esempio, esattamente a Oratino, sono stati ritrovati dei mucchi di ceci, fossilizzati, risalenti al XIV secolo a.C.. Cereali, legumi, ma anche tracce di allevamenti di pecore, buoi, capre: tutti indizi che ci danno una idea di quello che poteva essere il regime dietetico del periodo. Non esistono testimonianze letterarie circa l’alimentazione dei Sanniti, eppure le fattezze territoriali, le documentazioni legate a storia, stili di vita ed economia, possono farci immaginare molto. In una ricca sepoltura di Ururi è stato ritrovato un modellino in terracotta di una biga con cavalli al galoppo e auriga: il reperto è stato rinvenuto insieme ai resti di un pasto funebre che riesce ancora a raccontare il legame diretto con il cibo, seppure simbolico, e il rituale che caratterizzava le popolazioni sannitiche del V secolo a.C.. Non vi sono, inoltre, testimonianze di ricettari o trattati gastronomici sanniti, così come è accaduto per gli antichi Romani, ma una cosa è certa: ancora oggi le tavole sannite vengono imbandite con gli stessi alimenti del popolo progenitore, che Tito Livio definì “montani atque agrestes”. La loro vita era dura e frugale e gli alimenti della terra erano sicuramente i più consumati. Sembra che il pasto principale presso i Sanniti, così come per i Romani, fosse la cena, attorno all’ora IX, cioè tra il mezzogiorno e il tramonto, quando si rincasava dopo una lunga e intensa giornata di lavoro.
Molto consumati erano le lattughe, il cavolo, il porro, ma anche erbe lassative, malve e bietole. Venivano mangiati i legumi sia freschi che secchi, crudi, bolliti o arrostiti. Le fave avevano un ruolo di primaria importanza: si pensava, infatti, che attraverso il loro gambo le anime dei morti raggiungessero l’aldilà, tanto che per i pitagorici erano un tabù, poiché cibo dei morti per eccellenza. Esse venivano consumate fresche, appena tolte dal baccello, arrostite oppure preparate a mo’ di purea. I lupini costituivano un alimento di basso prezzo, adatto a tutte le tasche, mentre i restanti legumi venivano bolliti con acqua e latte per poi essere spolverati da formaggio. Aglio, cipolla e cetrioli erano molto noti e consumati cotti o secchi, specie nelle zuppe ma anche come accompagnamento delle principali pietanze. La lattuga invece si trovava solo sulle tavole delle famiglie più abbienti, condita solitamente con olio e aceto. Essa veniva considerata come la causa dell’indebolimento degli organi sessuali mentre la rucola era considerata afrodisiaca. Le ghiande venivano cotte sotto la cenere e mangiate come sfizio dopo pasto. Più di 700 mila anni fa, nella località Pineta di Isernia, esse venivano scheggiate e utilizzate nella caccia ai bisonti.
E proprio la caccia era una delle occupazioni preferite dei Sanniti, più per l’approvvigionamento del cibo che per sport o divertimento. Gli Irpini particolarmente si sostentavano con tale attività, come testimoniato da scene raffigurate nelle pitture tombali delle necropoli sabelle. La macellazione degli animali avveniva in determinate occasioni o giorni, per poi essere distribuita e cotta alla brace oppure bollita in tegami di terracotta, modalità utilizzata soprattutto per la preparazione delle carni più dure, come la pecora. Ancora oggi, a Capracotta, nel Molise, si mangia carne di pecora, così come il toponimo ci suggerisce. Probabilmente il brodo ottenuto dalla cottura veniva mangiato con il pane. Si riteneva migliore la carne dell’animale che aveva appena passato la giovinezza, per cui né troppo tenero né troppo adulto. Si preferiva la carne dell’animale femmina tranne che per il fagiano, mentre tra i maschi si preferivano i castrati. Le femmine si evitavano nel periodo in cui allattavano i propri piccoli. L’odierna lepre in salmì ha origini proprio dalla tradizione che la vedeva cucinata con una salsa piccante. A volte, però, veniva preferita quella arrostita o ricoperta da olio e formaggio accompagnata da spezie varie. Alcune tombe di Alfedena hanno restituito resti di cibo che lasciano pensare a una zuppa di farro piuttosto densa, simile alla polenta. Il farro costituiva il cibo tradizionale degli antichi popoli italici e lo si lavorava con un macinetto di pietra o mortaio: si faceva cuocere la farina da esso prodotto nell’acqua salata, da condire con olio o miele, talvolta mescolato con formaggio fresco, uova, o anche con vino, cervella e aromi. Già a quei tempi si lavoravano diverse tipologie e forme di pane. Il pane nero veniva consumato prevalentemente dagli atleti. Vi era, poi, un tipo di pane di crusca e del pane più “lussuoso”, che poteva essere prodotto dalla lievitazione o meno con acqua salata. Per le occasioni speciali, come feste religiose o civili, si lavoravano pani dolci a base di miele e mandorle, uva passa e droghe.

I frutti conosciuti erano le mele, le pere, le ciliegie, le susine, le noci, le mandorle e le castagne. I primi agrumi provenivano dal lontano Oriente e l’uva, sia fresca che “passa”, veniva conservata in recipienti di coccio. Con le mele cotogne si producevano ottime e digeribilissime marmellate, da mangiare rigorosamente con le dita per poi pulirsi con la mollica di pane. La frutta veniva anche conservata grazie all’essiccamento al sole, per poter essere poi consumata nella stagione più fredda. Castagne e noci venivano raccolte appena iniziava l’autunno, e costituivano ulteriore frutta secca adatta all’alimentazione invernale. Le nocciole e le mandorle spesso venivano consumate di sera per impedire l’ubriacatura, mentre i pinoli potevano essere serviti cotti nel miele.
Il Sannio era una terra molto feconda e l’agricoltura era la regina per l’economia. La zona di Alife, di Venafro e del Monte Taburno erano molto fertili, così come tutta l’area del Sangro. La montagna regalava buonissimi prodotti del bosco e del sottobosco. I funghi venivano consumati solitamente crudi, grazie alla loro tenerezza e al piacevole profumo che emanavano. Molto probabilmente i Sanniti conoscevano anche i tartufi, specie nella Pentria, ottima produttrice di questo oro nero che cresce sotto terra ancora oggi. L’allevamento dei bovini veniva praticato sin dalla Preistoria, come indicato dai tori che fungevano da animali guida nei rituali del Ver Sacrum e dall’esistenza di una città di nome Bovianum, ma anche dalle allusioni a mandrie di mucche contenuta nella letteratura arrivata fino a noi. Nella zona del Matese, come oggi, era molto fiorente la produzione di latticini. Il latte di mucca e di capra poteva essere usato fresco, mentre quello di pecora, a causa del troppo grasso presente, si destinava alla lavorazione dei prodotti caseari, che così potevano essere consumati anche durante gli inverni più rigidi. Venivano allevati anche cavalli, asini, muli, pollame, capre, maiali. Le pecore erano molto importanti anche per la notevole produzione della lana. Anche le uova abbondavano sulle tavole dei Sanniti. Importante anche a livello sacro, in quanto, data la loro forma, richiamavano le uova d’argento da cui ebbe inizio il Cosmo, esse venivano consumate fresche ma anche cotte, soprattutto in acqua, e in composti di farina di farro o con miele e frutta come elemento base dei dolci.
La bevanda principale era l’acqua mulsa o idromele, ossia miele e acqua fermentata con frutti come mele, pere, lamponi e sambuco. Il vino era la bevanda più nobile ed eccitante, e la coltivazione che predominava era certamente quella della vite. L’eccellente vino di Beneventum aveva un aroma leggermente affumicato ed era menzionato già nel IV secolo, quando la città non aveva ancora tale toponimo. Esso veniva conservato in recipienti di terracotta e di legno e poteva essere usato per accompagnare i pasti, proprio come oggi. Quando veniva utilizzato caldo, e servito nelle coppe tramite mestoli, ci si intingeva del pane, a volte unendoci dei chicchi di farro. Questa era una pratica perlopiù invernale. A volte al vino caldo veniva aggiunto zucchero, pepe o un po’ di pasta di formato piccolo: si trattava del famoso scattone, che ancora oggi troviamo nelle zone molisane. Alcuni dolci venivano impastati con il mosto e proprio questi possono essere considerati i progenitori dei mostaccioli. Il mosto del vino bianco era il lievito che veniva utilizzato nell’impasto di questo tipico dolce del Sud Italia. E a proposito di dolci, un impasto simile veniva schiacciato fino all’ottenimento di cialde molto sottili portate sul fuoco con due ferri riuniti a forma di forbici, proprio come le molisane cialde e ferratelle di oggi. In ogni caso, il culmine di un’alimentazione ricca e varia, molto bilanciata, proprio come la dieta mediterranea vuole.