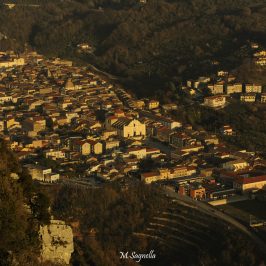Foto di Marilina Foschini
Nel Sannio, beneventano o pentro, il Martedì Grasso si mangia tanto, fino a scoppiare. Se è vero, infatti, che il Carnevale è la festa più colorata e allegra che ci sia, la pancia deve prepararsi a contenere grandi porzioni di cibo. Un tripudio di sapori e aromi, prima del periodo di magro che segna la Quaresima. E così, dal Giovedì Grasso fino al martedì successivo, le cucine sannite sono veri e propri laboratori di arte culinaria.
In molte zone, la tradizione carnevalesca per eccellenza è la lasagna, solitamente farcita di uova sode, formaggi e carne. Polpettine o salsiccia tritata, poco importa: l’essenziale è che sia rossa e rigorosamente fatta in casa. Quando non si prepara la lasagna, solitamente si ricorre agli gnocchi al sugo: alla sorrentina o al tegamino, di solito vengono preparati anche per la forma rotonda, simile a quella dei coriandoli.
A Castelvenere, borgo nel cuore del Sannio beneventano, la scarpella è il piatto tipico di carnevale. Ha origini contadine, tanto da venir preparato, quando se ne ha la possibilità, in pentole di coccio o in pietra lavica coperte dalla brace, direttamente nel camino. Si può utilizzare lo stesso impasto di una pastiera salata, ma può essere realizzata anche con pasta corta, bianca, in forno, condita con i prodotti tipici della dispensa contadina: salsiccia secca, formaggio vaccino fresco, formaggio stagionato grattugiato, uova sbattute e olio rigorosamente extravergine di oliva. Un piatto di cui non si conosce l’origine, la cui particolarità sta nel fatto che di casa in casa variano le proporzioni degli ingredienti, i formati della pasta e a volte le modalità di cottura. Il piatto è gustosissimo, soprattutto se abbinato al vino rosso-violaceo tipico del paese, la Camaiola. A dire il vero, anche a Solopaca c’è l’antica usanza della scarpella, anche qui con diverse modalità di preparazione.
Altra presenza gastronomica sulle tavole sannite, che ritroveremo anche nel periodo pasquale, è la pastiera salata, una sorta di timballo di spaghetti o linguine, burro, parmigiano e pecorino, uova, e pezzettini di salame e salsiccia secca.
Dolci in quantità, direi immancabilmente. Le scorpelle sono dei tipici dolci del Carnevale della tradizione molisana, molto rinomati anche a Morcone e a Pontelandolfo. Vengono chiamate anche cartellate e sono semplici negli ingredienti, anche se è richiesta una buona manualità nella costruzione della “rosetta”, con le varie strisce di pasta che la compongono.
Le scorpelle richiamano molto le zeppole di San Giuseppe. Fatte di farina, uova, strutto, vino bianco, scorza di arancio e olio per la frittura, sempre rigorosamente extravergine di oliva, sono ottime da gustare con il prelibato miele sannita.
Regina delle tavole molisane è la cicerchiata, la cui etimologia riporta alle origini medievale della cicerchia, un legume simile a piselli o ceci. Il dolce è riconosciuto come P.A.T. per l’Abruzzo, le Marche e il Molise, ma è largamente diffuso anche in altre regioni. È molto simile agli struffoli napoletani, il dolce natalizio dalle palline un po’ più grandi. I confetti i colorati richiamano il brio dei coriandoli. Anche i caragnoli, volgarmente detti Caragnol, sono caratteristici dolci molisani, sia del periodo natalizio che di quello carnevalesco. Si tratta di ghiotte frittelle a forma di elica ricoperte di miele
La graffa è una tradizione tutta partenopea. Nasce a Napoli, di cui è regina dello streetfood. Il suo antenato è il krapfen austriaco, ideato da Cecilia Krapf, cuoca alla corte d’Asburgo e Vienna. Ecco, dunque, l’assonanza tra i due nomi. Nel periodo austriaco, a Napoli fu riadattata la classica ricetta. Farina, burro e uova accomunano i due preparati, ma la graffa nell’impasto prevede anche la presenza di patate, che ne donano una caratteristica sofficità. Il krapfen, tra l’altro, viene passato nello zucchero a velo, la graffa, invece, nello zucchero semolato appena cacciato dall’olio bollente. Nel beneventano, ovviamente, un goccio di liquore Strega nell’impasto non manca mai.
Nel carnevale sannita si degustano anche le frittelle veneziane, ma in particolar modo il migliaccio e i ravioli dolci.
Il migliaccio è un piatto tipico della tradizione carnevalesca campana, e nei comuni della Valle Caudina consiste in una specie di polenta cotta al forno o fritta, nelle varianti dolce e salata. La prima è la variante povera della sfogliatella napoletana, tanto che se ne avvicina molto, come sapore e consistenza, proprio al ripieno. Ecco perché in Valle Caudina il migliaccio viene chiamato sfogliata. Pochi e semplici gli ingredienti che lo compongono. Anticamente veniva utilizzato il miglio, mentre oggi, per la preparazione di questo dolce, viene usato il semolino. Gli altri sono la ricotta, le uova, la scorza d’arancio e lo zucchero. Alcune varianti prevedono invece l’essenza di fiori d’arancio e/o il rum.
I ravioli dolci, invece, sono dei gusci croccanti con una base simile alla frolla, che custodiscono farciture sempre differenti, come marmellata, crema, cioccolato, ricotta. Al forno o fritti, l’importante è che non manchi mai la ricotta, purché secca. Questa rappresenta un ingrediente essenziale. Anche in questo caso, un tocco di liquore beneventano non guasta.

Foto di Salvatore Di Fiore
Le chiacchiere sono golose strisce dentellate, che richiamano la forma dei nastri o delle stelle filanti carnevalesche. Non sono tipicamente sannite, anzi le troviamo sulle tavole di tutta Italia, preparate seguendo ricette molto simili, a dispetto dei molti appellativi dialettali. Frappe oppure bugie, sfrappole, cenci, crostoli, pampuglie, ma anche galani e lasagne: questi sono i tanti i nomi che indicano una delizia unica nel suo genere.
Le castagnole sono dolcetti a forma sferica, che spesso vengono mangiati assoluti, altre volte con un ripieno alla crema, e che hanno gli stessi ingredienti delle chiacchiere. Quelle beneventane hanno l’ovvio tocco magico che è il liquore Strega. La loro forma richiama molto quella dei coriandoli del Carnevale. La provenienza è emiliano – romagnola e prendono il nome dalla caratteristica forma affine a quella delle castagne. Diffuse in particolar modo nel periodo che va dall’Epifania al Martedì Grasso, anche le castagnole hanno nomi differenti in base alle zone geografiche di produzione e/o consumo.
.